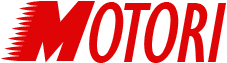Stati generali per la salute… dell’aria
di Marco Baroni*
La scienza medica e le sue ricadute sulla salute? È ora di cambiare. Tutto. Nell’impostazione accademica, nella comunicazione, nel controllo delle informazioni, nella liturgia degli eventi scientifici. Non per un desiderio di una qualche rivoluzione iconoclastica che sempre hanno provocato al genere umano solo male, ma per porre fine ad un modo superato di procedere e di intervenire in questo rapporto che necessita di un rinnovamento radicale.
A onor del vero, le cose, intorno al tema centrale della salute, sono già cambiate. Basti solo pensare all’incremento esponenziale della vita media (con la conseguente crescita di persone inabili e spesso bisognose di assistenza continua), alla globalizzazione con l’avvento di nuove esigenze e nuove culture, alla diffusione planetaria di internet (che permette a tutti di accedere in maniera indiscriminata ai risultati della ricerca scientifica ma anche alle sue peggiori interpretazioni), allo straordinario procedere della tecnologia nello studio e nel trattamento delle malattie, al ruolo dell’informazione sempre più aggressiva e spesso superficiale anche nel campo scientifico.
E questo è solo un semplice elenco degli aspetti del profondo cambiamento che ha subito il mondo della salute negli ultimi due decenni. Un processo che non conosce soste o rallentamenti.
A tale proposito scrivevo in un editoriale di circa vent’anni fa sulla rivista “Argomenti di Sanità e Salute”, da me fondata e diretta, che le nazioni, soprattutto quelle avanzate e di conseguenza i loro governi, avrebbero dovuto fare i conti entro pochi anni soprattutto con il problema della salute, che sarebbe diventato quindi “il” problema. Non credo di aver sbagliato di molto, sia in termini temporali sia in termini di sostanza. Perché, se è vero che l’economia sembra essere l’unico termometro di valutazione per un progetto di società, è altrettanto vero che la popolazione in generale e i singoli cittadini guardano principalmente ai risultati di un tale progetto in termini di salute, benessere e qualità della vita.
Ecco quindi che risulta improcrastinabile una nuova impostazione del progresso anche nel campo della scienza medico-biologica e delle sue ricadute sulla salute. Se la salute, quindi, come afferma l’OMS è uno “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale…” e diritto inalienabile di ogni essere umano, è necessario affrontare i temi universali diversamente da come si sono affrontati fino a oggi.
In questi decenni sono ovviamente stati fatti passi da gigante sul tema della prevenzione, della diagnosi precoce e nel campo dell’educazione sanitaria, ma è giunto il momento di cambiare strada.
Le strategie devono tenere conto della complessità dei problemi non riconducibili solo all’ambito scientifico e sanitario, in particolare per le dimensioni fondamentali della vita e della salute: dormire, mangiare, respirare. Ormai i soggetti che in qualche modo intervengono, anche pesantemente, aiutati dalla comunicazione ipertrofica, su questi aspetti centrali della vita biologica sono molti, pur non facendo parte del mondo che tradizionalmente e storicamente si occupa di salute. Per quanto riguarda i primi due aspetti, il mangiare e il dormire, i soggetti in gioco sono molto numerosi ma anche più controllabili, in quanto in buona parte dipendenti dalla scelte individuali.
Riguardo al respiro invece, è evidente che non si può prescindere dalla qualità dell’aria che evidentemente non dipende dal singolo.
Ma fino ad ora questa è stata materia oggetto prevalentemente di dibattito politico e di analisi ambientale.
La scienza medica si è limitata a descrivere e a denunciare i risvolti sulla salute dell’inquinamento dell’aria. Mai ha cercato di affrontare il problema ponendosi come obiettivo la “terapia”; come se non fosse suo compito. Ma senza il coinvolgimento fattivo e responsabile del mondo produttivo le grida di allarme rischiano di restare lettera morta.
Ecco quindi che mettere intorno a un tavolo chi studia il fenomeno dal punto di vista biologico e chi può contribuire concretamente al miglioramento della qualità dell’aria con una politica riguardo ai trasporti di riduzione delle emissioni nocive non solo può costituire un primo, fondamentale passo in avanti per la risoluzione del problema ma favorire una integrazione dei saperi e delle responsabilità che ormai nel mondo contemporaneo deve diventare prassi comune nell’affrontare i grandi problemi.
Una politica diversa e aperta al confronto costruttivo con i vari settori della società civile costituisce una sorta di rivoluzione copernicana del mondo della ricerca e della medicina in particolare e per questo può incontrare resistenze e suscitare perplessità, a volte anche condivisibili. Ma il rischio di essere travolti dal “cambiamento” senza regole determinato dalla diffusione della comunicazione sempre più incontrollata e trovarsi a dover sempre inseguire e subire le “regole del gioco” senza più la prospettiva di poter orientare le scelte di fondo anche nel campo della salute è troppo alto. Col risultato di abdicare a quello che dovrebbe essere compito primario della scienza medica: comunicare ed educare. Senza per questo ritornare ad un concetto di onnipotenza della scienza, retaggio di un mondo ormai scomparso, ma non per questo rinunciare a percorrere vie nuove.
Una alleanza strategica e illuminata tra i settori più avanzati e sensibili di mondi finora distanti e impermeabili alle contaminazioni come quelli dei produttori di carburanti e di automezzi e della ricerca medica e ambientale è uno dei caposaldi di questa proposta.
Lavorare insieme in commissioni miste per elaborare strategie e diffondere documenti e informazioni il più possibile spendibili al grande pubblico, inserire nei comitati direttivi e decisionali delle aziende figure che rappresentino il mondo scientifico e viceversa responsabili delle strategie commerciali nei comitati scientifici che studino il problema, in una sorta di “stati generali” per la salute, in questo caso dell’aria, è una strada certamente inusuale e mai sperimentata. Bisognevole di pionieri. Ma l’avventura umana ha quasi sempre ottenuto vantaggi dalle esplorazioni di vie nuove.
*Medico specialista in malattie respiratorie e comunicatore