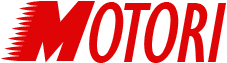112, come funziona e come dovrebbe funzionare il numero unico di emergenza
di Lorenzo Borselli*
Il 1-1-2 come il 9-1-1 statunitense? In Italia, per ora, è solo fantascienza e il fatto che, a macchia di leopardo, qualche centrale operativa NUE (Numero Unico di Emergenza) sia partita, non deve ingannare. Il servizio, secondo noi, non funziona: non perché, sia chiaro, non ci piaccia l’idea di poter avere un numero unico da chiamare. Il fatto è che vorremmo, da operatori di pubblica sicurezza, idee chiare e un ruolo primario nella gestione delle emergenze che l’attuale organizzazione non garantisce.
Chi chiama il NUE, dov’è attivo, parla prima con un “laico” della CUR (Centrale Unica di Risposta), il quale stabilisce poi a quale centrale di secondo livello, la PSAP2 (public-safety answering point), inoltrare la chiamata: Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato/ Carabinieri); soccorso tecnico urgente (Vigili de! fuoco); emergenza Sanitaria
Un “laico”, per quanto formato, non potrà mai sostituire un professionista qualificato, che per l’attuale pianificazione del NUE subentra sempre in un secondo momento e affermiamo questo su una base di logica deduzione e sulla nostra esperienza diretta. Il recente tragico evento di San Giovanni a Piro (Salerno), nel quale ha perso la vita il turista francese Simon Gautier, precipitato in un dirupo e trovato morto lo scorso 18 agosto, dopo ben 9 giorni di ricerche scaturite dalla sua stessa chiamata al 112, impone una seria riflessione, da compiere su due piani diversi.
Il primo: nella zona non opera il NUE; il secondo: le nostre centrali operative, siano esse di primo e secondo livello, non sono all’altezza dei tempi moderni e nel corso di questo contributo proviamo a spiegare perché, sempre, ovviamente, secondo la nostra opinione.
Sembra che le lesioni riportate dal povero Simon, nella sua caduta, abbiano provocato un’emorragia massiva che lo avrebbe ucciso in poco meno di un’ora, ma se il nostro Paese disponesse della tecnologia in uso altrove, per esempio in Francia, Simon sarebbe stato trovato in pochissimo tempo e, forse, si sarebbe salvato. Una tragedia che ci mette davvero in imbarazzo con il resto del mondo e, soprattutto, con noi stessi.
Partiamo da un assunto: cos’è una centrale operativa, noi, lo sappiamo. Sappiamo cosa significa rispondere a una chiamata “isterica”, sappiamo cosa significa gestire le decine di telefonate che arrivano tutte insieme per segnalare un fatto grave, sappiamo cosa significa dover interloquire con una persona straniera che chiede aiuto. Sappiamo anche cosa significa dover processare un intervento comunicando le necessità da uno scenario operativo evolvente alle altre diverse centrali di soccorso, in primis quelle del 118 o del 115, per avere il loro contributo sul teatro.
Esempio: segnalazione di incidente stradale al 113 (ovviamente in autostrada o in viabilità principale). La chiamata viene girata alla Polizia Stradale, che perde subito i dati relativi al chiamante, perché deviata dalla Questura. Bisogna localizzare l’evento, capire cosa stia accadendo, il numero di veicoli e persone coinvolte, condizioni fisiche, rischi imminenti. L’operatore invia la pattuglia, comunica alla sala operativa della società concessionaria o dell’Anas l’evento, contatta il 118 per le ambulanze e il 115 per gli altri rischi, come ad esempio la presenza di veicoli in fiamme, di vittime incarcerate nelle lamiere o il coinvolgimento di veicoli in ADR.
Questo, ovviamente, dove non è ancora attivo il N.U.E., oggi in funzione in soli otto distretti (Friuli-Venezia Giulia, Lazio – prefisso 06 – Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia Orientale, Valle d’Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano), e in avviamento in altri tre: dove il NUE è attivo, si perde secondo noi solo del tempo perché l’operatore di primo livello, il “laico” di cui parlavamo prima, deve effettuare una serie di domande per farsi un’idea di ciò che è appena accaduto e, poi, girare la chiamata.
Perché? La risposta a tale interrogativo consisterebbe nel limitare la mole di chiamate inutili che perverrebbero alle varie centrali scremandone una metà “perché non di vera emergenza”. Ben venga il numero unico, ma la centrale deve essere una sola, composta da operatori di tutte le forze in campo. Insomma, una unità di crisi sempre pronta ad entrare in azione, con medici e infermieri, vigili del fuoco e forze di polizia, tutti in un unico ambiente condiviso. Riteniamo di parlare a ragion veduta, da tecnici e da tali, ovviamente, abbiamo il nostro punto di vista.
Cosa è successo a Simon Gautier? Secondo le cronache, Simon, esperto di trekking, avrebbe iniziato il suo giro la mattina del 9 agosto. Dopo aver lasciato la traccia del sentiero principale e avventuratosi su una traccia secondaria, il giovane sarebbe salito su alcune rocce, da cui sarebbe poi precipitato. A seguito della caduta, siamo alle 9 circa, Simon chiama il 112 (numero europeo di emergenza) per chiedere aiuto: la chiamata, ricevuta dai Carabinieri di Lagonegro (Potenza), viene subito girata al 118 lucano, che non dispone di un servizio di geolocalizzazione (fornito dalle forze dell’ordine, quando necessario). Dopo una breve interlocuzione, il 118 lucano contatta il 118 di Vallo della Lucania (Salerno), che allerta i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino. Simon, a questo punto ha già smesso di rispondere e la geolocalizzazione della sua prima chiamata, resa disponibile dai sistemi circa un’ora e mezzo dopo, è così approssimativa dall’essere riferita a un’area di 143 chilometri quadrati.
Un’infinità.
Cosa è mancato? Semplice: l’adozione della tecnologia, che ha un costo, e che il nostro Paese non ha ancora comprato. Si chiama AML (Advanced Mobile Location), un sistema che, anche in assenza di rete Internet, consente di far partire in automatico dallo smartphone di chi richiede il soccorso, un sms al 112 “che comunica le coordinate GPS corrispondenti esattamente al punto in cui si trova la vittima”, come spiegato all’Adnkronos da Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistema (Sis) 118. Balzanelli ha anche ricordato quanto più volte polemicamente ribadito da Jérôme Pâris, direttore della European Emergency Number Association (Eeena), secondo il quale l’AML dovrebbe essere “già attivo in Italia”, visto che il nostro Paese “ha già ricevuto denaro pubblico europeo per una prima fase di test nel 2016/2017”. Siamo alle solite.
Come dovrebbe funzionare? La localizzazione AML del chiamante permette agli operatori del 112 di ricevere immediatamente le informazioni relative al chiamante: comune, via e numero civico, nel caso di telefoni fissi ed esatta ubicazione sul territorio per i telefoni mobili con un’approssimazione che varia dai 10 metri dei centri urbani, ai 200 metri delle aree rurali o poco abitate. Tra le funzioni più importanti, c’è quella di inviare i soccorsi qualora il chiamante non sappia dove esattamente si trovi o non sia nelle condizioni di fornire informazioni (ad esempio, che sia in stato di semi-incoscienza o che sia disperso in alta montagna). Nel caso di Simon, in un dirupo sul mare.
Il tutto, in due secondi: il tempo di ricevere il dato e di inserirlo in una mappa a video. Nel caso di Simon, non sarebbero serviti centinaia di volontari, ma una squadra tecnica e sanitaria eliportata che, probabilmente, sarebbe stata sul posto una mezz’ora dopo la chiamata. In tempo per salvarlo? Nessuno può dirlo, ma è un fatto che il 27enne sia stato ritrovato cadavere ben nove giorni dopo l’incidente, il che è un tempo sul quale è perfettamente inutile polemizzare: l’inchiesta della Procura di Vallo della Lucania cercherà di spiegare anche questo.
Come funziona in realtà? Proviamo a spiegarlo: il caso di Gautier non è isolato. Ai primi di gennaio di quest’anno, ad esempio, un ottantenne di Bologna, Gianni Boldini, ha chiamato i soccorsi per ore, spiegando di aver perso l’orientamento e di essersi infortunato durante una passeggiata sui colli tra Pianoro e Sasso Marconi. Nessuno ha potuto determinare la sua posizione con certezza e nessuno l’ha più ritrovato. Perché? Quando a una delle centrali operative 112, 113, 115 o 118 arrivano chiamate del genere, l’unica cosa da fare oggi è determinare l’ultima cella telefonica agganciata dal cellulare, ma si tratta di informazioni relative ad aree di copertura, la cui ampiezza varia da zona a zona.
Solo Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco possono avviare la procedura, mentre il 118 non potrà fare a meno di una delle centrali di polizia o dei pompieri. La strada è accidentata: si determina innanzitutto quale sia l’operatore del numero da cui è scaturita l’emergenza. In Italia ci sono 4 operatori titolari di rete MNO, Mobile Network Operator (ILIAD, TIM, Vodafone, Wind-Tre) e ben 18 operatori virtuali MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Esiste anche un quinto operatore titolare, Rete Ferroviaria Italiana, ma si tratta di una rete telefonica solo commerciale, riservata appunto ai ferrovieri.
Chi riceve la chiamata dovrà prima accertare questo, componendo ad esempio il numero da cui è scaturita la chiamata d’emergenza preceduto da “456”, oppure inserendo il numero in una delle banche dati del Ministero dell’Interno. La prima opzione è sicuramente quella più rapida, perché per avere un esito completo dalla banca dati ETNA (Elenco Telefonico Nazionale, a volte servono ore).
Se invece il numero è straniero, quello di un turista, la situazione si fa più complessa, perché il dato sulla cella impegnata sarà fornito dall’operatore su cui al momento sarà attivo il roaming; se invece si tratta di operatori virtuali, bisognerà stabilire su quale rete siano essi appoggiati (quindi ILIAD, TIM, Vodafone o Wind-Tre). Un esempio: Lycamobile si appoggia su rete Vodafone. Una volta capito questo, parte una PEC con la richiesta di acquisizione dell’ultimo dato disponibile: è per questo che spesso si inviano sms al numero da rintracciare, perché al momento della loro ricezione si ottengono informazioni circa le ultime celle agganciate.
Tutto qua: nessuna coordinata GPS e, quindi, nessuna informazione precisa. Se il numero ricercato è in città, il campo si restringe a qualche metro, se è in una zona rurale è come cercare un ago in un pagliaio, soprattutto se nell’area rurale non ci sono strade ma, come nel caso del povero Gautier o del pensionato bolognese Gianni Boldini, solo sentieri, magari nemmeno segnati.
(*) Ispettore della Polizia di Stato, responsabile nazionale comunicazione di ASAPS